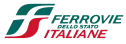Periferia
Degrado sociale, mancanza di infrastrutture e servizi, migranti, poveri e delinquenza. Questo è lo stereotipo attaccato ai quartieri periferici delle grandi città. Come spesso accade, però, i luoghi comuni non corrispondono ai luoghi reali e, anche in caso di somiglianza: quali sono le cause?
 In Italia, secondo Giovanni Semi, professore di Sociologia e di Culture urbane all’Università di Torino e autore del libro Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, abbiamo assistito nell’arco degli ultimi trent’anni a un processo di trasformazione che ha cambiato il volto delle città: "Nel nostro Paese ci sono due dinamiche: l’aumento costante del consumo di suolo per l’edilizia e la diminuzione della popolazione. In Italia oggi ci sono meno abitanti di quanti ce ne fossero dieci anni fa. Questo fenomeno si chiama ‘periferizzazione’ e comporta la crescita fisica delle aree ai bordi della città. Gli andamenti dei valori immobiliari sono impressionanti". In sostanza, le periferie si allargano. Tutto ciò sembra inspiegabile se si considera che in Italia, secondo gli ultimi dati Istat (del 2011) riguardo alle case vuote, su un totale di 31 milioni di abitazioni, 7 milioni risultano inabitate. Quasi una casa su quattro è vuota e i picchi di questa situazione si riscontrano maggiormente in Calabria, con un 40%, e in Valle da Aosta, con il 50%. Come mai quindi allargare le città? Le risposte sono molteplici. Una è che buona parte degli immobili vuoti si trova al di fuori dei grandi centri, in zone da cui la popolazione si sposta per motivi di studio o in cerca di lavoro. Dall’altro, come spiega Semi, "l’80% delle famiglie ha una casa di proprietà. Poi si aggiunge una quota piccolissima, circa il 3%, protetta dagli alloggi popolari. Il restante 17% paga affitti che sono mediamente piuttosto alti rispetto alla qualità dell’immobile. Proprio in periodi di crisi di reddito, come quello che stiamo vivendo, i proprietari di casa preferiscono togliere dal mercato le abitazioni che avere degli inquilini insolventi. Questo genera un enorme stock abitativo vuoto, cui corrisponde una sempre maggiore quantità di poveri senzatetto. Gli homeless aumentano, infatti, proporzionalmente alle case sfitte".
In Italia, secondo Giovanni Semi, professore di Sociologia e di Culture urbane all’Università di Torino e autore del libro Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, abbiamo assistito nell’arco degli ultimi trent’anni a un processo di trasformazione che ha cambiato il volto delle città: "Nel nostro Paese ci sono due dinamiche: l’aumento costante del consumo di suolo per l’edilizia e la diminuzione della popolazione. In Italia oggi ci sono meno abitanti di quanti ce ne fossero dieci anni fa. Questo fenomeno si chiama ‘periferizzazione’ e comporta la crescita fisica delle aree ai bordi della città. Gli andamenti dei valori immobiliari sono impressionanti". In sostanza, le periferie si allargano. Tutto ciò sembra inspiegabile se si considera che in Italia, secondo gli ultimi dati Istat (del 2011) riguardo alle case vuote, su un totale di 31 milioni di abitazioni, 7 milioni risultano inabitate. Quasi una casa su quattro è vuota e i picchi di questa situazione si riscontrano maggiormente in Calabria, con un 40%, e in Valle da Aosta, con il 50%. Come mai quindi allargare le città? Le risposte sono molteplici. Una è che buona parte degli immobili vuoti si trova al di fuori dei grandi centri, in zone da cui la popolazione si sposta per motivi di studio o in cerca di lavoro. Dall’altro, come spiega Semi, "l’80% delle famiglie ha una casa di proprietà. Poi si aggiunge una quota piccolissima, circa il 3%, protetta dagli alloggi popolari. Il restante 17% paga affitti che sono mediamente piuttosto alti rispetto alla qualità dell’immobile. Proprio in periodi di crisi di reddito, come quello che stiamo vivendo, i proprietari di casa preferiscono togliere dal mercato le abitazioni che avere degli inquilini insolventi. Questo genera un enorme stock abitativo vuoto, cui corrisponde una sempre maggiore quantità di poveri senzatetto. Gli homeless aumentano, infatti, proporzionalmente alle case sfitte".
 In Italia, secondo Giovanni Semi, professore di Sociologia e di Culture urbane all’Università di Torino e autore del libro Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, abbiamo assistito nell’arco degli ultimi trent’anni a un processo di trasformazione che ha cambiato il volto delle città: "Nel nostro Paese ci sono due dinamiche: l’aumento costante del consumo di suolo per l’edilizia e la diminuzione della popolazione. In Italia oggi ci sono meno abitanti di quanti ce ne fossero dieci anni fa. Questo fenomeno si chiama ‘periferizzazione’ e comporta la crescita fisica delle aree ai bordi della città. Gli andamenti dei valori immobiliari sono impressionanti". In sostanza, le periferie si allargano. Tutto ciò sembra inspiegabile se si considera che in Italia, secondo gli ultimi dati Istat (del 2011) riguardo alle case vuote, su un totale di 31 milioni di abitazioni, 7 milioni risultano inabitate. Quasi una casa su quattro è vuota e i picchi di questa situazione si riscontrano maggiormente in Calabria, con un 40%, e in Valle da Aosta, con il 50%. Come mai quindi allargare le città? Le risposte sono molteplici. Una è che buona parte degli immobili vuoti si trova al di fuori dei grandi centri, in zone da cui la popolazione si sposta per motivi di studio o in cerca di lavoro. Dall’altro, come spiega Semi, "l’80% delle famiglie ha una casa di proprietà. Poi si aggiunge una quota piccolissima, circa il 3%, protetta dagli alloggi popolari. Il restante 17% paga affitti che sono mediamente piuttosto alti rispetto alla qualità dell’immobile. Proprio in periodi di crisi di reddito, come quello che stiamo vivendo, i proprietari di casa preferiscono togliere dal mercato le abitazioni che avere degli inquilini insolventi. Questo genera un enorme stock abitativo vuoto, cui corrisponde una sempre maggiore quantità di poveri senzatetto. Gli homeless aumentano, infatti, proporzionalmente alle case sfitte".
In Italia, secondo Giovanni Semi, professore di Sociologia e di Culture urbane all’Università di Torino e autore del libro Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, abbiamo assistito nell’arco degli ultimi trent’anni a un processo di trasformazione che ha cambiato il volto delle città: "Nel nostro Paese ci sono due dinamiche: l’aumento costante del consumo di suolo per l’edilizia e la diminuzione della popolazione. In Italia oggi ci sono meno abitanti di quanti ce ne fossero dieci anni fa. Questo fenomeno si chiama ‘periferizzazione’ e comporta la crescita fisica delle aree ai bordi della città. Gli andamenti dei valori immobiliari sono impressionanti". In sostanza, le periferie si allargano. Tutto ciò sembra inspiegabile se si considera che in Italia, secondo gli ultimi dati Istat (del 2011) riguardo alle case vuote, su un totale di 31 milioni di abitazioni, 7 milioni risultano inabitate. Quasi una casa su quattro è vuota e i picchi di questa situazione si riscontrano maggiormente in Calabria, con un 40%, e in Valle da Aosta, con il 50%. Come mai quindi allargare le città? Le risposte sono molteplici. Una è che buona parte degli immobili vuoti si trova al di fuori dei grandi centri, in zone da cui la popolazione si sposta per motivi di studio o in cerca di lavoro. Dall’altro, come spiega Semi, "l’80% delle famiglie ha una casa di proprietà. Poi si aggiunge una quota piccolissima, circa il 3%, protetta dagli alloggi popolari. Il restante 17% paga affitti che sono mediamente piuttosto alti rispetto alla qualità dell’immobile. Proprio in periodi di crisi di reddito, come quello che stiamo vivendo, i proprietari di casa preferiscono togliere dal mercato le abitazioni che avere degli inquilini insolventi. Questo genera un enorme stock abitativo vuoto, cui corrisponde una sempre maggiore quantità di poveri senzatetto. Gli homeless aumentano, infatti, proporzionalmente alle case sfitte".