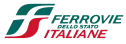Allarme siccità in Italia
Mai come quest’anno la Giornata Mondiale dell’ONU per la lotta a desertificazione e siccità, che si è celebrata il 17 giugno, assume le caratteristiche di un monito, più che di una ricorrenza. Dai dati Ispra, infatti, risulta che più di un quarto del territorio nazionale (28%) è a rischio desertificazione. Un rischio che non riguarda più solo le regioni del Sud, ma oramai anche quelle del Nord, con la costante diminuzione della disponibilità idrica nelle campagne e nelle città, l’arrivo di autobotti e lo spettro dei razionamenti. E siamo solo all’inizio dell’estate che, anzi, da calendario, non è ancora cominciata. Più che un elenco, quello della carenza d’acqua, sembra un bollettino di guerra. A partire dal principe dei fiumi italiani: il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca che è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni, e a preoccupare è anche l’avanzare del cuneo salino per la risalita dell’acqua di mare che rende impossibile la coltivazione nelle zone del delta. In sofferenza anche il lago Maggiore con un grado di riempimento del 22,7%, così come quello di Como che è al 30,6%.

 In Piemonte i benefici apportati dai brevi, ma intensi fenomeni meteo, registrati la settimana scorsa, sono già statai vanificati dalla perdurante ondata di calore, cosicché il deficit pluviometrico provoca livelli di falda quasi ovunque al di sotto dei minimi storici, mentre la riserva di neve risulta azzerata con 2 mesi d’anticipo. Stessa situazione (niente più neve sui monti e falde a secco) si registra in Veneto, dove il fiume Adige si mantiene su livelli minimi rispetto al passato così come gli altri corsi d’acqua della regione. "La situazione è però difficile lungo tutta la Penisola in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate che ha portato a cambiare anche le scelte di coltivazione sul territorio con – continua la Coldiretti – un calo stimato di diecimila ettari delle semine di riso che ha più bisogno di acqua a favore della soia, con un impatto economico, occupazionale ma anche ambientale". A preoccupare – precisa la Coldiretti – è la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo come il grano che fa segnare quest’anno un calo del 15% delle rese alla raccolta ma in difficoltà ci sono girasole, mais, e gli altri cereali ma anche quella dei foraggi per l’alimentazione degli animali e di ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere“.
In Piemonte i benefici apportati dai brevi, ma intensi fenomeni meteo, registrati la settimana scorsa, sono già statai vanificati dalla perdurante ondata di calore, cosicché il deficit pluviometrico provoca livelli di falda quasi ovunque al di sotto dei minimi storici, mentre la riserva di neve risulta azzerata con 2 mesi d’anticipo. Stessa situazione (niente più neve sui monti e falde a secco) si registra in Veneto, dove il fiume Adige si mantiene su livelli minimi rispetto al passato così come gli altri corsi d’acqua della regione. "La situazione è però difficile lungo tutta la Penisola in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate che ha portato a cambiare anche le scelte di coltivazione sul territorio con – continua la Coldiretti – un calo stimato di diecimila ettari delle semine di riso che ha più bisogno di acqua a favore della soia, con un impatto economico, occupazionale ma anche ambientale". A preoccupare – precisa la Coldiretti – è la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo come il grano che fa segnare quest’anno un calo del 15% delle rese alla raccolta ma in difficoltà ci sono girasole, mais, e gli altri cereali ma anche quella dei foraggi per l’alimentazione degli animali e di ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere“.



Sui ghiacciai del Grand Etrét in Valle d'Aosta l'accumulo di neve è di 127 centrimenti, il livello più basso mai registrato
L'allarme di Coldiretti: "A rischio in Italia oltre il 30% della produzione agricola"
Nel bacino padano per la mancanza di acqua, secondo quanto denuncia Coldiretti, “è minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo, ma in alcune zone di Piemonte e Lombardia non piove da quasi tre mesi e in certi Paesi si ricorre alle autobotti per l’uso civile mentre sui ghiacciai del Trentino è stata misurata una quantità di neve compresa tra il 50% e il 60% del valore medio della serie storica“. In Valle d’Aosta uno studio della Società Meteorologica ha certificato la grave condizione, in cui versano i ghiacciai del Grand Etrét (Valsavarenche) e Ciardoney (Val Soana): nel primo, l’accumulo di neve medio è di 127 centimetri, vale a dire il livello più basso finora registrato ed inferiore di circa il 62% rispetto alla media del periodo 2000-2021 (cm. 331) e dell’11% per quanto riguarda la normale densità; anche sul ghiacciaio Ciardoney, le misure di accumulo confermano la situazione di scarsità estrema con spessori di neve, che vanno da cm. 165 nel punto più elevato ad appena 25 centimetri nel settore mediano, cioè il 25% dei livelli generalmente rilevati, segnandoo il record negativo in tempi recenti.
il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca che è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni

In Toscana l'Arno ha flussi dimezzati di acqua rispetto alla media mensile: quasi 50.000 litri al secondo in meno rispetto a giugno 2020
Fiumi a secco, la drammatica situazione nel Centro Italia
Al Centro, secondo i dati ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni) è esemplare è la situazione di quello che “era” il secondo fiume della Toscana, ovvero l’Ombrone, che è ridotto ormai ad uno stato torrentizio dopo mesi di sofferenza idrica e registra attualmente una portata di 890 litri al secondo, quando il minimo per garantire la vita in alveo è indicato in l/s 2000. L’Arno, che pure se la cava meglio, grazie all’invaso del Bilancino, ha flussi dimezzati rispetto alla media mensile e, in particolare, quasi 50.000 litri al secondo in meno rispetto al Giugno 2020. Nelle Marche, il fiume Sentino tocca già il minimo storico (-37 centimetri), registrato nell’Agosto 2021, anno considerato idricamente critico per la regione; anche Esino e Nera sono ai livelli più bassi del recente quinquennio, mentre gli invasi ancora trattengono volumi idrici superiori a quelli di 12 mesi fa. In Umbria, il fiume Tevere, nel suo tratto iniziale, registra il livello più basso (cm. 35) dal 1996, mentre gli invasi del lago Trasimeno e della diga Maroggia sono praticamente dimezzati rispetto agli anni scorsi), ma non solo: Nel Lazio, particolarmente grave è la situazione dell’Aniene, ridotto ad una portata di circa 3.000 litri al secondo contro una media di oltre l/s 8.000; crolla anche la portata del Sacco, così come in calo sono i livelli dei laghi romani: Nemi scende a cm. 47 contro m.1,66 del Giugno 2021 e Bracciano ha un livello inferiore di 25 centimetri all’anno scorso).
L'allarme di Coldiretti: "A rischio in Italia oltre il 30% della produzione agricola"