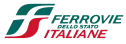luce1
Certo, i cambiamenti climatici, certo le emissioni di C02, ma la fragilità climatica ed idrogeologica del nostro Paese ha anche una spiegazione che punta dritto dritto al modo in cui realizziamo i nostri insediamenti, ed all’urbanizzazione sempre più congestionata che si riscontra nella penisola. Il consumo di suolo in Italia continua infatti a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate. Secondo il consueto rapporto annuale curato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), solo nell’ultimo anno “le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 km2 , ovvero, in media, più di 15 ettari al giorno”. Si tratta di un incremento che rimane in linea con quelli rilevati nel recente e fa perdere al nostro Paese quasi 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, causando la perdita di aree naturali e agricole, che vengono sostituite da nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale all’interno e all’esterno delle aree urbane esistenti.

 E come se non bastasse, “si assiste a una crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in molti casi di decrescita, dei residenti” a testimonianza del fatto che siamo di fronte ad un fenomeno che perdura anche in presenza di variabili demografiche negative. Il suolo consumato pro capite aumenta in un anno di 1,92 m2 , passando da 357 a 359 m2 /ab, a fonte dei 349 m2 /ab nel 2015. La copertura artificiale del suolo è ormai arrivata al 7,11% (7,02% nel 2015, 6,76% nel 2006) rispetto alla media UE del 4,2%. La percentuale nazionale sale al 9,15% all’interno del suolo utile, ovvero quella parte di territorio teoricamente disponibile e idonea ai diversi usi.
E come se non bastasse, “si assiste a una crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in molti casi di decrescita, dei residenti” a testimonianza del fatto che siamo di fronte ad un fenomeno che perdura anche in presenza di variabili demografiche negative. Il suolo consumato pro capite aumenta in un anno di 1,92 m2 , passando da 357 a 359 m2 /ab, a fonte dei 349 m2 /ab nel 2015. La copertura artificiale del suolo è ormai arrivata al 7,11% (7,02% nel 2015, 6,76% nel 2006) rispetto alla media UE del 4,2%. La percentuale nazionale sale al 9,15% all’interno del suolo utile, ovvero quella parte di territorio teoricamente disponibile e idonea ai diversi usi.




Ristrutturazione di un'area di edilizia residenziale a Bologna: esempio di risparmio di suolo
Compensazione parziale
Questa crescita, spiega ancora ISPRA è “solo in parte compensata dal ripristino di aree naturali, pari quest’anno a 5 km2 , dovuti al passaggio da suolo consumato a suolo non consumato (in genere grazie al recupero di aree di cantiere o di superfici che erano state già classificate come consumo di suolo reversibile)”. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano che i valori netti dei cambiamenti nell’ultimo anno sono pari a 51,7 km2 , equivalenti a 1,72 m2 per ogni ettaro di territorio italiano. In aggiunta, si deve considerare che 8,2 km2 sono passati, nell’ultimo anno, da suolo consumato reversibile, a suolo consumato permanente, sigillando ulteriormente il territorio. In particolare, l’impermeabilizzazione è quindi cresciuta, complessivamente, di 18 km2 , considerando anche il nuovo consumo di suolo permanente.
Il rifacimento di una facciata
Ora a rischio anche Abruzzo e Molise
I cambiamenti rilevati nell’ultimo anno sono particolarmente elevati in Lombardia (12,08%), Veneto (11,87%) e Campania (10,39%) e, in generale nelle pianure del Nord. Il fenomeno rimane molto intenso anche lungo le coste siciliane e della Puglia meridionale e nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna. Gradi elevati di trasformazione permangono lungo quasi tutta la costa adriatica. In termini di incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno precedente, i valori più elevati sono in Abruzzo (+0,46%), Molise (+0,37%), Sardegna (+0,32%) Veneto, Lazio e Puglia (+0,31%). Mentre in termini di suolo consumato pro capite, il Molise presenta il valore più alto (576 m2 /ab), oltre 200 m2 in più rispetto al valore nazionale (359 m2 /ab), seguita da Basilicata (571 m2 /ab) e Valle d’Aosta (559 m2 /ab). Sicilia, Lombardia, Liguria, Campania e Lazio presentano i valori più bassi e al di sotto del valore nazionale. Limitandosi alla crescita annuale, Molise (2,15 m2 /ab) e Abruzzo (1,91 m2 /ab), sono le due regioni che presentano valori superiori al doppio del dato nazionale sul consumo di suolo pro capite (0,87 m2 /ab).
Tre torri di edilizia popolare residenziale a Tor Bella Monaca a Roma
Zone vicine alla costa e campi nelle città
In particolare, sottolinea Ispra “la maggior densità dei cambiamenti è stata registrata quest’anno lungo la fascia costiera entro un chilometro dal mare, nelle aree di pianura, nelle città e nelle zone urbane e periurbane dei principali poli e dei comuni di cintura, in particolare dove i valori immobiliari sono più elevati e a scapito, principalmente, di suoli precedentemente agricoli e a vegetazione erbacea, anche in ambito urbano”.Roma capitale del consumo di suolo
La provincia dove il consumo di suolo netto è cresciuto di più nel 2020 è Roma con 271 ettari di nuovo suolo artificiale, seguita da Brescia (+214) e Vicenza (+172). Crescite significative, comprese tra 100 e 170 ettari nell’ultimo anno, si riscontrano anche a Verona, Torino, Bari, Padova, Sassari, Lecce, Bergamo, Novara, Foggia, Chieti, Catania, Treviso. In percentuale rispetto al valore del 2019 i valori più elevati sono quelli di Cagliari (+0,86%), Novara (+0,77%), Chieti (+0,68%) e Ascoli Piceno (+0,56%). Monza e Brianza si conferma la provincia con la percentuale di suolo consumato più alta, con circa il 41% di suolo consumato in rapporto alla superficie provinciale e un ulteriore incremento di 27 ettari.Troia, un "primato" dovuto al fotovoltaico
Roma, con un incremento di superficie artificiale di 123 ettari, si conferma anche quest’anno il comune italiano che più ha trasformato il suo territorio. Singolarmente invece, il secondo comune per consumo di suolo del 2020 è Troia (Foggia), con 66 ettari di incremento. La spiegazione? “ l’origine di questo consumo di suolo -dice Ispra - va ricercata nell’ampliamento delle superfici destinate all’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, su aree precedentemente agricole”.
Un impianto fotovoltaico con consumo di suolo
Addio suolo a Bari e Firenze
Tra i capoluoghi regionali, oltre a Roma, riscontriamo una crescita notevole delle superfici artificiali a Bari (+19), Firenze (+16), L’Aquila e Torino (entrambi con 14 ettari in più). Trieste, Cagliari e Campobasso confermano la tendenza dello scorso anno con variazioni inferiori all’ettaro.Temperature in aumento
Il consumo di suolo è più intenso nelle aree già molto compromesse e contribuisce a far diventare sempre più calde le nostre città, con il fenomeno delle isole di calore e la differenza di temperatura estiva tra aree a copertura artificiale densa o diffusa che, rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle città più grandi, viceversa, Dice Ispra “il consumo di suolo è meno intenso all’interno delle aree protette (dove si registrano comunque 65 ettari in più nell’ultimo anno) e nelle aree montane, ma è invece evidente all’interno delle aree vincolate per la tutela paesaggistica (+1.037 ettari), entro i 10 km dal mare (+1.284 ettari), in aree a pericolosità idraulica media (+767 ettari), in aree a pericolosità da frana (+286 ettari) e in aree a pericolosità sismica (+1.852 ettari)”.Addio a quattro milioni di quintali di prodotti agricoli
In danno che se ne ricava è notevole. Secondo il rapporto ISPRA “Le aree perse in Italia dal 2012 avrebbero ad esempio garantito la fornitura complessiva di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli e l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde e aggravano la pericolosità idraulica dei nostri territori. Nello stesso periodo, la perdita della capacità di stoccaggio del carbonio di queste aree (circa tre milioni di tonnellate) equivale, in termini di emissione di CO2, a quanto emetterebbero oltre un milione di autovetture con una percorrenza media di 11.200 km l’anno tra il 2012 e il 2020: un totale di oltre 90 miliardi di chilometri percorsi, più di 2 milioni di volte il giro della terra. Questo consumo di suolo recente produce anche un danno economico potenziale che supera i 3 miliardi di euro ogni anno, a causa della perdita dei servizi ecosistemici del suolo”.
La zona residenziale di Napoli vista dal drone