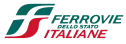chernobyl8

Anna Bardazzi assieme all'amica Ljuda, in Bielorussia
Quei silenzi di bambini sconosciuti
“Quando avevo vent’anni ero proprio come Anna. Non a caso le ho dato il mio nome: abbiamo in comune quello, ma anche il grande amore per la Bielorussia, nato più o meno allo stesso modo. Io, però, non mi sono mai messa in testa di salvare nessuno, ma una promessa alla me di allora l’ho fatta: avrei raccontato a qualcuno questa parte di mondo. Anch’io, quindi, proprio come la mia protagonista, ho respirato i silenzi di bambini sconosciuti che dormivano a pochi centimetri da me, per un mese l’anno, per tanti anni. Ho imparato come si dice anguria, come si pronuncia buonanotte e l’odore che hanno quei sacchetti di plastica, quando arrivano sempre troppo vuoti. Un giorno, pur senza avere nessuno da salvare, mi son detta: e se andassi là? E così mi sono ritrovata proprio come il mio personaggio a sorvolare distese di alberi innevati, laghi ghiacciati e piccole casette di legno fumanti in cui scorrevano vite che avrei poi conosciuto bene” racconta.Le redini in mano alle donne
Di viaggi così “ne ho fatti due, ventenne, come tante persone che in qualche modo sono passate dai progetti di accoglienza dei minori provenienti dalle aree contaminate dal disastro di Chernobyl. Poi, l’incontro che ha cambiato la mia vita: Liuda, in quell’estate del 2005 in cui decidemmo di ospitare un’accompagnatrice anziché un bambino. La stessa persona che, nel mio romanzo, tiene legate Anna e Lena, l’unica che esiste realmente al di fuori delle pagine scritte da me”. La storia di Anna e Lena è una storia di amicizia, ma soprattutto di forza: “quella che mi hanno insegnato in tutti questi anni, sono ormai diciotto, le donne bielorusse, tenaci, sorridenti, combattenti, dritte nella schiena e verso l’obiettivo. Aver raccontato di loro in questo momento storico, quello in cui hanno preso in mano le redini del loro Paese per traghettarlo verso un futuro dignitoso e finalmente libero, mi rende orgogliosa. Sapere di poter raccontare, al di là delle proteste, l’esistenza di donne che lottano per una vita migliore, mi ricorda che a volte, sotto la coltre di fango dei primi disgeli di marzo, si cela proprio la felicità”. Lena e Anna, un’amicizia che nasce dalla diffidenza dello sconosciuto e che diventa nel corso degli anni energia pura. E dopo vent’anni si rafforza nonostante la lontananza di migliaia di chilometri. Un infuso di ottimismo, la fotografia che possiamo essere meglio di quello che sembriamo se mettiamo da parte gli egoismi? “Sì, è quello che ho imparato non solo frequentando ormai da anni la Bielorussia, un paese molto aperto nonostante spesso si pensi diversamente, ma anche grazie alla mia famiglia. In casa nostra la porta è sempre stata aperta per tutti, ed è proprio così che mia mamma ha deciso di ospitare i bambini del Progetto Chernobyl. Basta poco per essere solidali col prossimo e spesso non serve nemmeno andare lontano”. La sinergia dell’amicizia appartiene alle persone che hanno voglia di condividere. Le donne, racconta, ne sono protagoniste. E insieme riescono a fare piccole, grandi rivoluzioni. Il suo è un inno al women power per reazione a una società limitatamente maschilista o la consapevolezza che le donne sono più determinate e forti di quello che la società vuole mostrare e soprattutto considerare? “Sicuramente in questo periodo c’è una rivoluzione in atto, alcuni la chiamano femminismo 3.0, ma io credo che sia semplice consapevolezza. Dopo anni in cui le donne erano viste solo come opzione di cura nella società, oggi si prendono un ruolo più attivo, grazie anche ai passi avanti fatti dall’uomo che si occupa di casa, figli e genitori proprio quanto la compagna. In Bielorussia ho conosciuto molte famiglie matriarcali, non perché l’uomo non avesse un ruolo importante, ma perché le donne hanno sempre saputo trainare la società in ogni ambito, personale, professionale e politico. Un bellissimo esempio per noi che ancora spesso ci perdiamo in lotte tutte femminili su chi sia più “donna”, quella che lavora e riesce a far tutto o quella che si dedica alla cura dei propri cari”. Eppure le donne devono sempre dimostrare qualcosa per essere all’altezza. Come mai? Retaggio culturale? Paura di perdere certezze consolidate? Ignoranza? “Sicuramente il retaggio culturale ha un ruolo preponderante. Se penso alle nostre nonne spesso ho davanti immagini di donne che avevano molti figli e al tempo stesso lavoravano per bisogno. Era possibile grazie anche alla condivisione: le famiglie erano molto uniti e ci si aiutava con ogni mezzo. Con il boom economico sembrava fosse cosa giusta occuparsi dei figli e della casa, e questa mentalità è ancora dura da sradicare. E di certo c’è anche ignoranza, perché la cultura aiuta ad approcciarsi al ruolo della donna in modo diverso, più moderno e meno bianco o nero”. Quel passaggio della Barbie dalla mano di una bambina occidentale cresciuta nel comfort sociale a una bambina già segnata da una tragedia (Chernobyl) che significato ha? Testimonia che l’affetto non conosce barriere, che i sentimenti non hanno confini? “Anna ha tutto quello che vuole, da sempre: una bella casa, genitori amorevoli, giochi in abbondanza e ogni opportunità. Eppure sembra rincorrere un sogno di felicità sempre più lontano, sposta continuamente l’asticella perché per una come lei felicità non equivale a semplicità. La sua amica Lena, invece, è cresciuta in un paese complesso, straziato ancora dalle conseguenze della guerra, dalla caduta dell’Unione Sovietica, dal disastro di Chernobyl. Per lei felicità non significa oggetti, non significa porsi obiettivi sempre più grandi. Per lei felicità è vivere appieno le relazioni e poter scegliere della propria vita. Una felicità, la sua, costruita giorno per giorno, vivendo il qui e oggi. Resta da scoprire se Anna se ne convincerà, prima o poi, e in che modo”.
Lena e Anna, un’amicizia che nasce dalla diffidenza dello sconosciuto e che diventa nel corso degli anni energia pura. E dopo vent’anni si rafforza nonostante la lontananza di migliaia di chilometri. Un infuso di ottimismo, la fotografia che possiamo essere meglio di quello che sembriamo se mettiamo da parte gli egoismi? “Sì, è quello che ho imparato non solo frequentando ormai da anni la Bielorussia, un paese molto aperto nonostante spesso si pensi diversamente, ma anche grazie alla mia famiglia. In casa nostra la porta è sempre stata aperta per tutti, ed è proprio così che mia mamma ha deciso di ospitare i bambini del Progetto Chernobyl. Basta poco per essere solidali col prossimo e spesso non serve nemmeno andare lontano”. La sinergia dell’amicizia appartiene alle persone che hanno voglia di condividere. Le donne, racconta, ne sono protagoniste. E insieme riescono a fare piccole, grandi rivoluzioni. Il suo è un inno al women power per reazione a una società limitatamente maschilista o la consapevolezza che le donne sono più determinate e forti di quello che la società vuole mostrare e soprattutto considerare? “Sicuramente in questo periodo c’è una rivoluzione in atto, alcuni la chiamano femminismo 3.0, ma io credo che sia semplice consapevolezza. Dopo anni in cui le donne erano viste solo come opzione di cura nella società, oggi si prendono un ruolo più attivo, grazie anche ai passi avanti fatti dall’uomo che si occupa di casa, figli e genitori proprio quanto la compagna. In Bielorussia ho conosciuto molte famiglie matriarcali, non perché l’uomo non avesse un ruolo importante, ma perché le donne hanno sempre saputo trainare la società in ogni ambito, personale, professionale e politico. Un bellissimo esempio per noi che ancora spesso ci perdiamo in lotte tutte femminili su chi sia più “donna”, quella che lavora e riesce a far tutto o quella che si dedica alla cura dei propri cari”. Eppure le donne devono sempre dimostrare qualcosa per essere all’altezza. Come mai? Retaggio culturale? Paura di perdere certezze consolidate? Ignoranza? “Sicuramente il retaggio culturale ha un ruolo preponderante. Se penso alle nostre nonne spesso ho davanti immagini di donne che avevano molti figli e al tempo stesso lavoravano per bisogno. Era possibile grazie anche alla condivisione: le famiglie erano molto uniti e ci si aiutava con ogni mezzo. Con il boom economico sembrava fosse cosa giusta occuparsi dei figli e della casa, e questa mentalità è ancora dura da sradicare. E di certo c’è anche ignoranza, perché la cultura aiuta ad approcciarsi al ruolo della donna in modo diverso, più moderno e meno bianco o nero”. Quel passaggio della Barbie dalla mano di una bambina occidentale cresciuta nel comfort sociale a una bambina già segnata da una tragedia (Chernobyl) che significato ha? Testimonia che l’affetto non conosce barriere, che i sentimenti non hanno confini? “Anna ha tutto quello che vuole, da sempre: una bella casa, genitori amorevoli, giochi in abbondanza e ogni opportunità. Eppure sembra rincorrere un sogno di felicità sempre più lontano, sposta continuamente l’asticella perché per una come lei felicità non equivale a semplicità. La sua amica Lena, invece, è cresciuta in un paese complesso, straziato ancora dalle conseguenze della guerra, dalla caduta dell’Unione Sovietica, dal disastro di Chernobyl. Per lei felicità non significa oggetti, non significa porsi obiettivi sempre più grandi. Per lei felicità è vivere appieno le relazioni e poter scegliere della propria vita. Una felicità, la sua, costruita giorno per giorno, vivendo il qui e oggi. Resta da scoprire se Anna se ne convincerà, prima o poi, e in che modo”.  Cosa le ha insegnato la campagna del Progetto Chernobyl? Accoglienza del ‘diverso’ che diventa uguale. E’ stato un progetto di formazione per il futuro che ha poi vissuto? “Quando ero adolescente e già conoscevo tanti bambini arrivati da Russia, Bielorussia e Ucraina mi dicevo che non avrei mai avuto un figlio perché i bambini in Italia crescono viziati, mentre loro, i “bambini di Chernobyl”, per me erano gioia pura. La gioia di mangiare un gelato, di tuffarsi in mare, di scoprire. Poi sono cresciuta e ho capito che potevo fare tesoro di quello che mi ha insegnato questa esperienza: non è giusto pensare che un popolo sia migliore, meno viziato, semplicemente perché non ha stabilità economica e opportunità. È giusto invece lottare perché tutti abbiano le stesse opportunità e insegnare ai bambini di oggi, adulti di domani, che la felicità sta nelle piccole cose, che la vita è un dono sempre. Che gli oggetti, le possibilità economiche, aiutano, ma da sole non sono tutto. Ed è così che cerco ci crescere le mie figlie, che sono già state in Bielorussia diverse volte e che hanno imparato, proprio come me, a riconoscere il bello nella vita di tutti i giorni. O almeno, spero di esserci riuscita!”. Tanta vita vissuta in Bielorussia. Che cosa si porta con sé adesso che vive a Milano, una città dove sembra che la competitività sia dominante? “Vivere in Bielorussia è stata un’esperienza che ha sicuramente cambiato la mia vita, ma non potrei stabilirmi in un paese in cui non c’è democrazia e non vengono rispettati i diritti umani. Per quanto se ne dica, in Italia abbiamo ancora opportunità, anche se vorremmo cambiare tante cose. La competitività ha anche i suoi aspetti positivi, a volte porta a migliorarsi, ma appunto solo laddove ci venga data la possibilità di fare ciò che si vuole, cosa che non è possibile in Bielorussia a causa del regime. Come dicono le mie protagoniste, in un mondo ideale la società sarebbe un mix perfetto della nostra e della loro: democrazia, libertà, ma anche rispetto dei valori, solidarietà, amore per la natura e per le cose semplici”. I suoi natali pratesi e il senso di appartenenza. La città più multiculturale d’Italia. Capace di accogliere nei decenni tra il 1950 e 1960 la migrazione dal sud d’Italia e nel 2000 di essere stravolta dall’arrivo di comunità straniere, prima tra tutte quella cinese. Cosa le è rimasto addosso di Prato, città di frontiera? “Sono fiera di essere pratese proprio per questi motivi. Sono cresciuta con una famiglia cinese, quando la migrazione era appena iniziata, a fine anni Ottanta, sempre grazie alla grande apertura di mia madre. Ricordo che mi lasciava a casa loro, un piccolo appartamento in via Bologna condiviso con altre famiglie, e mi ritrovavo a mangiare uova dei cent’anni e altri piatti che per me, che avevo sette anni, erano come cibi alieni. Eppure mia mamma riusciva a renderlo naturale, senza timori. Trovo che la multiculturalità sia il fondamento dell’evoluzione, perché si ha spesso paura di ciò che non si conosce. A Prato ci sono tanti brontoloni, eppure c’è anche tanta solidarietà, tanta integrazione. Mi piace vedere, quando torno, come le varie culture si mescolano e piano piano si riconoscono. Per me che ho vissuto dieci anni a Parigi, trovare Prato così moderna, seppure con tante complessità, mi rende davvero orgogliosa”.
Cosa le ha insegnato la campagna del Progetto Chernobyl? Accoglienza del ‘diverso’ che diventa uguale. E’ stato un progetto di formazione per il futuro che ha poi vissuto? “Quando ero adolescente e già conoscevo tanti bambini arrivati da Russia, Bielorussia e Ucraina mi dicevo che non avrei mai avuto un figlio perché i bambini in Italia crescono viziati, mentre loro, i “bambini di Chernobyl”, per me erano gioia pura. La gioia di mangiare un gelato, di tuffarsi in mare, di scoprire. Poi sono cresciuta e ho capito che potevo fare tesoro di quello che mi ha insegnato questa esperienza: non è giusto pensare che un popolo sia migliore, meno viziato, semplicemente perché non ha stabilità economica e opportunità. È giusto invece lottare perché tutti abbiano le stesse opportunità e insegnare ai bambini di oggi, adulti di domani, che la felicità sta nelle piccole cose, che la vita è un dono sempre. Che gli oggetti, le possibilità economiche, aiutano, ma da sole non sono tutto. Ed è così che cerco ci crescere le mie figlie, che sono già state in Bielorussia diverse volte e che hanno imparato, proprio come me, a riconoscere il bello nella vita di tutti i giorni. O almeno, spero di esserci riuscita!”. Tanta vita vissuta in Bielorussia. Che cosa si porta con sé adesso che vive a Milano, una città dove sembra che la competitività sia dominante? “Vivere in Bielorussia è stata un’esperienza che ha sicuramente cambiato la mia vita, ma non potrei stabilirmi in un paese in cui non c’è democrazia e non vengono rispettati i diritti umani. Per quanto se ne dica, in Italia abbiamo ancora opportunità, anche se vorremmo cambiare tante cose. La competitività ha anche i suoi aspetti positivi, a volte porta a migliorarsi, ma appunto solo laddove ci venga data la possibilità di fare ciò che si vuole, cosa che non è possibile in Bielorussia a causa del regime. Come dicono le mie protagoniste, in un mondo ideale la società sarebbe un mix perfetto della nostra e della loro: democrazia, libertà, ma anche rispetto dei valori, solidarietà, amore per la natura e per le cose semplici”. I suoi natali pratesi e il senso di appartenenza. La città più multiculturale d’Italia. Capace di accogliere nei decenni tra il 1950 e 1960 la migrazione dal sud d’Italia e nel 2000 di essere stravolta dall’arrivo di comunità straniere, prima tra tutte quella cinese. Cosa le è rimasto addosso di Prato, città di frontiera? “Sono fiera di essere pratese proprio per questi motivi. Sono cresciuta con una famiglia cinese, quando la migrazione era appena iniziata, a fine anni Ottanta, sempre grazie alla grande apertura di mia madre. Ricordo che mi lasciava a casa loro, un piccolo appartamento in via Bologna condiviso con altre famiglie, e mi ritrovavo a mangiare uova dei cent’anni e altri piatti che per me, che avevo sette anni, erano come cibi alieni. Eppure mia mamma riusciva a renderlo naturale, senza timori. Trovo che la multiculturalità sia il fondamento dell’evoluzione, perché si ha spesso paura di ciò che non si conosce. A Prato ci sono tanti brontoloni, eppure c’è anche tanta solidarietà, tanta integrazione. Mi piace vedere, quando torno, come le varie culture si mescolano e piano piano si riconoscono. Per me che ho vissuto dieci anni a Parigi, trovare Prato così moderna, seppure con tante complessità, mi rende davvero orgogliosa”.