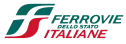Lara Lugli in campo
Lo sport italiano ha un grosso
problema con le mamme:
non le vuole. Difficile dirlo con un giro di parole più sfumato, cercando giustificazioni e appigli. Tra
contratti "capestro",
insulti dei fan e
richieste di risarcimento, la maternità per le atlete italiane è troppo spesso
un incubo più che un sogno. Chissà quante sono, lì fuori, sui campi, in pista o in vasca, le varie
Carli Ellen Lloyd o
Lara Lugli, solo per citare gli ultimi casi eclatanti.
La prima, palleggiatrice e capitana del Casalmaggiore, a settembre 2020 è stata
insultata pesantemente dai tifosi per aver osato rimanere
incinta in corso di carriera. La seconda, schiacciatrice, all'inizio di quest'anno è stata
citata per danni dalla sua ex squadra, il Volley Pordenone, per
non aver detto di volere dei figli al momento del contratto. Contratto, peraltro, che grazie a una clausola apposita, si era già
sciolto proprio a causa della gravidanza, lasciando la pallavolista senza lavoro e senza stipendio. Una prassi tutta italiana, che se la racconti all'estero non ci credono. Il caso di Lara ha però avuto il merito di riaccendere i riflettori sulle gravissime storture del sistema sportivo italiano nei confronti delle donne, che sono tutte, anche quelle ai massimi livelli, inquadrate come "dilettanti".
La situazione delle atlete in Italia
“Quando è uscito il caso di Lara, con la
rescissione del contratto per maternità e pure la
richiesta dei danni - spiega
Luisa Rizzitelli, combattiva presidente e fondatrice dell'
associazione Assist, che dal 2000 si batte per i diritti delle atlete italiane e più in generale per una parità di diritti nello sport - dal
New York Times mi hanno chiamata due volte perché non ci potevano credere. Mi dicevano ‘
But this is illegal!’”. E già, suona incredibile a tutti tranne che alle società sportive e alle federazioni. Ecco cosa succede nel nostro Paese: “Gli accordi fatti tra società sportive e donne atlete, di qualunque disciplina e a qualunque livello,
non sono contratti di lavoro, sono
accordi privati. E lì di norma viene scritto che la
maternità è causa di risoluzione del contratto. E se anche non c’è scritto, comunque si sa che è così”. Se non è chiaro quanto sia ingiusto, basti pensare che in Italia la legge prevede, a tutela della lavoratrice madre, la
nullità del licenziamento nel primo anno di vita del bambino. Ma il problema è che
l’atleta non è considerata una lavoratrice. “In Italia le sportive, anche quelle ai massimi livelli e che vivono di questo, sono considerate comunque dilettanti”.

Lara Lugli, pallavolista tesserata per la Volley Pordenone in B1
Dilettantismo: una stortura tutta italiana
Alla voce “dilettantismo” la Treccani scrive: “svolgimento di attività sportive senza intendimenti professionistici e senza mire di guadagno”. Ma risulta davvero difficile far ricadere in questa definizione tutte quelle donne che militano nelle
massime serie di
calcio, pallavolo, basket. E ancora,
Federica Pellegrini è una dilettante?
Francesca Piccinini (che ha appena annunciato l'addio alla carriera agonistica
ndr) è una dilettante? “La legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo - spiega
Luisa Rizzitelli - ha introdotto una novità che all’epoca sembrava innovativa ma si è rivelata un cappio. La legge dice che a decidere quali siano le discipline professionistiche siano il
Coni e le
Federazioni. Per il legislatore dovevano stabilire in una circolare dei criteri validi per tutti”. Così non è stato e
a oggi sono solo quattro le discipline che prevedono il professionismo: il
calcio fino alla Lega Pro, il
basket solo nella serie A1, il
golf e il
ciclismo su strada. Ma attenzione, solo per i
campionati maschili. “Per questo dico che in Italia la
più grande discriminazione delle donne è nell’ambito dello
sport”. Il motivo dell’esclusione delle donne? I soldi. “Le federazioni dicono che per essere professionistico, uno sport deve generare un giro economico rilevante, perché per le società il costo del lavoro è rilevante. Le uniche a battersi perché le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini siamo state
noi di Assist”.
La campagna #ioloso
Una delle ultime campagne social lanciate dall’associazione è
#ioloso. Io lo so che funziona così, ma
non mi sta più bene. Diversi atleti, uomini e donne, hanno posato con la palla sotto la maglia a mimare una gravidanza, per solidarietà con le atlete che devono rinunciare al lavoro se vogliono un figlio. Ma perché le atlete firmano quei contratti, se la clausola “anti-maternità” è palesemente ingiusta e impugnabile davanti a un
tribunale del lavoro? “Bisogna considerare, innanzitutto, un’altra incoerenza dello sport italiano: nonostante il dilettantismo, le
controversie sportive devono essere
trattate dalla giustizia sportiva. Se un’atleta vuole rivolgersi a un tribunale ordinario, deve essere
autorizzata dalla federazione. Ma in ogni caso, nessuna sportiva si rivolgerebbe a un giudice perché poi la sua carriera sarebbe finita. Lo sport è passione e questa situazione non agevola la difesa dei propri diritti”.

Nadia Rossi, slogan e pancione per la campagna #ioloso
Se tra gli atleti, anche uomini, la sensibilità su certi temi sta aumentando, non si può dire lo stesso delle
società. “Tranne rarissimi casi, che non riesco a contare nemmeno sulle dita di una mano, le società non si stanno allineando a questi temi: per loro
se un’atleta è incinta e non gioca più,
non deve essere pagata. Perché non sta più prestando la sua opera. Ma quello sportivo non è un lavoro autonomo, è
subordinato: ci sono
orari precisi,
obblighi, l
uoghi di lavoro,
divise. Senza considerare che se un uomo non può giocare perché si fa male, viene curato e di certo non perde il lavoro. Perché una donna, se ha un figlio, deve ritrovarsi senza lavoro, deve rimettersi in forma da sola e poi rimettersi sul mercato?”.
All’estero
“Negli altri Paesi succede che se sei un’atleta che vive di sport e percepisci uno stipendio per l’attività che svolgi, sei un lavoratore. E hai gli stessi diritti degli altri lavoratori. L’Italia e la sua
farsa del dilettantismo sono un’anomalia”.

Solidarietà maschile a #ioloso: l'ex saltatore in alto Giulio Ciotti in posa su Instagram col "pancione"
La riforma dello sport: cambierà qualcosa? Il 26 febbraio 2021, al fotofinish, sono stati approvati
cinque decreti legislativi della legge delega 86 dell’8 agosto 2019. Sulla carta, apportano grossi cambiamenti. Prevedono per esempio che
dal 2022 l’atleta dilettante possa stipulare
contratti di lavoro subordinato o autonomo e avrà diritto all’
assicurazione previdenziale e assistenziale a fronte del versamento dei contributi. Al momento invece vengono pagati con
rimborsi spese o premi. I decreti prevedono anche il riconoscimento del
professionismo femminile lì dove sono professionisti gli uomini. Tutto bene, dunque? No. In primis perché le federazioni non ci stanno e qualche settimana fa Figc, Fipav e Fip hanno scritto al premier
Mario Draghi: “Siamo favorevoli al riconoscimento di maggiori tutele a favore di atlete e atleti” ma le novità comportano “
gravi ripercussioni ai danni delle società sportive”. “Si trincerano dietro al costo del lavoro - prosegue Rizzitelli - ma è come se un’azienda qualsiasi si rifiutasse di pagare i contributi ai propri dipendenti perché costano. Comunque la legge non impone, chiede. E se chiedi non cambia nulla”.
Un palliativo: il fondo per la maternità delle atlete
Dove non vogliono arrivare le società, arriva lo Stato: la Legge di Bilancio 2018 ha istituito presso l’Ufficio per lo sport il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con lo scopo di destinare risorse al finanziamento, tra gli altri, di
iniziative a sostegno della maternità delle atlete
non professioniste (tutte). Un dpcm del 2919 ha poi definito risorse e criteri. Il fondo prevede un
contributo di mille euro per dieci mesi alle
atlete incinte che ne facciano richiesta, a condizione che la disciplina sportiva sia il
loro lavoro. Da giugno 2018 a febbraio 2020 il contributo è stato erogato a
36 atlete. “Diciamo che non è la soluzione di tutti i problemi ma è l’unica cosa buona di questi anni”.

Luisa Rizzitelli, fondatrice e presidente di Assist
I gruppi sportivi militari
Una menzione a parte, e molto negativa, merita il fenomeno dei gruppi sportivi militari. “Noi siamo contrarissimi! - spiega Rizzitelli -. Per tutelare gli atleti si militarizza lo sport di élite italiano perché lo sport italiano non vuole rimediare al problema del dilettantismo. Questa cosa
costa allo Stato 40 milioni l’anno, non è giusto. La riforma peraltro istituzionalizza questo fenomeno, che peraltro depaupera i vivai”.
I prossimi passi
“Noi siamo in pista per il
riconoscimento dei diritti del lavoro sportivo - conclude Rizzitelli - è una battaglia di cui beneficeranno anche gli atleti uomini. Io credo che basterebbe istituire un
fondo consistente per tutelare i diritti degli sportivi lavoratori, ma le società questa cosa non la vogliono proprio sentire. Tuttavia, sono vent’anni che
porto avanti questa battaglia e per la prima volta sento che siamo vicini alla meta”. Il vento sta cambiando? Può darsi. Una grossa spinta potrebbe darla la candidatura al Coni di
Antonella Bellutti, due volte campionessa olimpica e da sempre al fianco di Assist nella difesa dei diritti delle sportive. Belutti ha lanciato la campagna
Champs4Rights, un appello ai più grandi sportivi del passato affinché sostengano la sua
battaglia per il lavoro sportivo: “Dall’entrata in vigore della legge 91 del 1981 tale meraviglioso, estenuante lavoro attende di essere riconosciuto e normato da chi governa lo sport. Lo Stato ha dato un segnale positivo, approvando una riforma che tenta di disciplinarlo. Purtroppo ad osteggiare la riforma è lo stesso mondo dello sport, rappresentato dai presidenti federali. Proprio quei “nostri” presidenti che, mentre vincevamo anche per loro medaglie olimpiche, mondiali, europee, coppe e scudetti,
ignoravano le nostre esigenze di atleti e atlete senza contratto,
senza contributi previdenziali,
senza assicurazioni adeguate lasciandoci poi soli, a fine carriera, a reinventarci un’altra vita, lontani da un mondo sportivo che non ha più saputo o voluto coinvolgerci”.
#atletaemamma sarà la battaglia di Luce!
Luce! farà della tutela del diritto alla maternità delle atlete e in generale delle donne impegnate nello sport una propria battaglia, con l'hastag
#atletaemamma . Affinché il diritto di ogni donna ad essere madre sia tutelato con chiarezza anche in questo settore sempre più importante per la nostra società e non lasciato ogni volta al contenzioso fra atleta e società. Il parametro è la legge di
tutela delle lavoratrici madri, che in questo 2021 celebrerà i 50 anni dall'approvazione. Quella legge si fonda sulla considerazione che la maternità rappresenta un arricchimento della società e quindi è lo Stato ad accollarsi i relativi costi, coinvolgendo le parti sociali interessate. Perché non dev'essere così, anche nello sport?