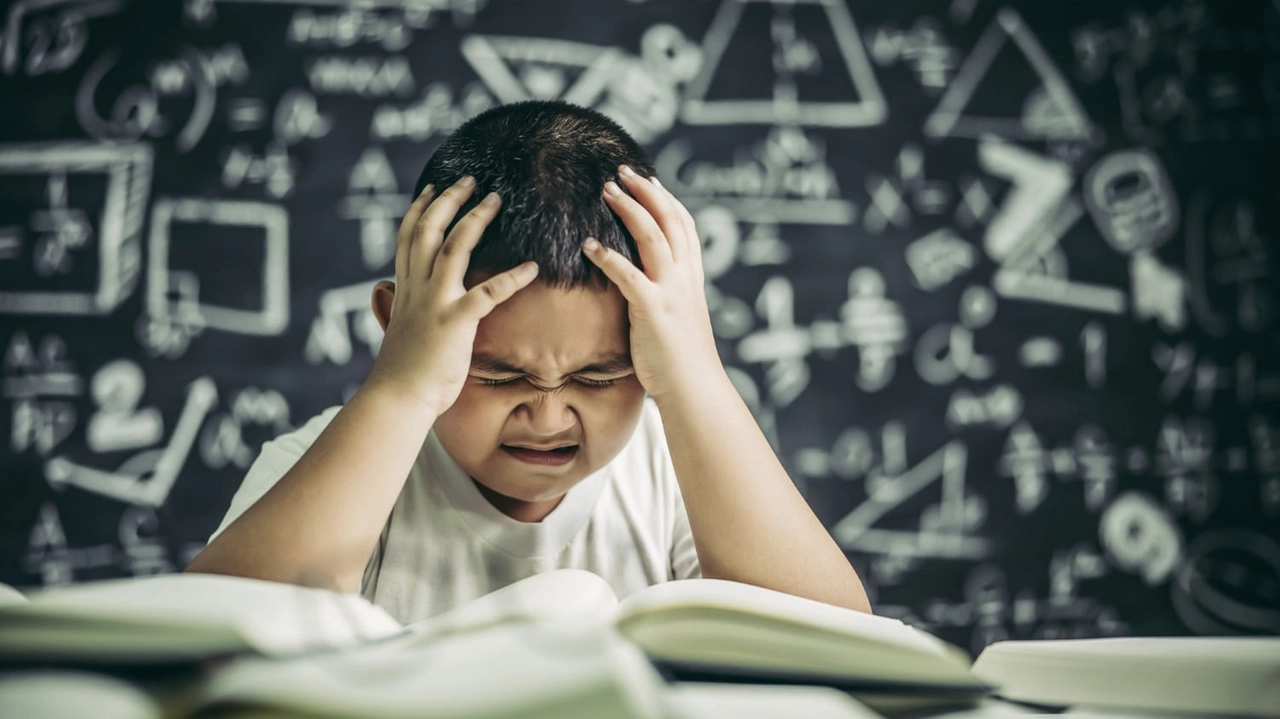
Insonnia, inappetenza, senso di nausea, frustrazione e aggressività. Sono solo alcuni dei sintomi che manifestano gli studenti di tutte le età, quando si sentono incapaci di gestire stress e ansia da prestazione legati alla scuola. Poco importa, come ci spiega il dottor Angelo Capasso - psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale e manager clinico della piattaforma di psicoterapia online Unobravo -, se si tratta di studenti universitari, liceali o addirittura di bambini di sei anni che mettono piede per la prima volta in una scuola elementare. Il senso di inadeguatezza, la paura del giudizio e il terrore di “non farcela” vengono percepiti comunque assai profondamente e possono generare conseguenze psico comportamentali anche gravi.




Angelo Capasso, psicoterapeuta sistemico-relazionale
Il peso delle aspettative sugli studenti
Dottor Capasso, in base alla sua esperienza, quali sono gli aspetti della scuola che generano più stress emotivo negli studenti? "Nella percezione dello stress vi è sempre una componente soggettiva, ragion per cui l’intensità del distress è diversa per ogni persona, tanto più per un individuo in fase di crescita che sta affrontando le prime sfide della vita. Accanto a componenti personali e familiari, che pure hanno un loro fondamentale peso nella gestione emotiva, mi vengono in mente due principali aspetti del sistema scolastico che possono comportare stress per gli studenti. Il primo è la performance: la scuola è un riflesso della società e al contempo una palestra in cui lo studente si allena a rispondere alle richieste sociali in cui andrà ad inserirsi. In una società sempre più performativa, le richieste scolastiche, esattamente come quelle sociali, possono diventare vere e proprie pressioni che non tutti riescono a tollerare. L’altro fattore sistemico di stress per lo studente è il tipo di prestazione che viene richiesto, che talvolta può non tener conto delle neuro-diversità e delle diverse tipologie di intelligenza, per cui alcuni allievi sono chiamati a fare maggiori sforzi cognitivi e avere comunque una minor resa rispetto ai coetanei. Quella fatica o quell’insuccesso possono contribuire alla creazione di una rappresentazione di sé negativa e lo studente si figura come incapace, non in grado, stupido, “meno degli altri”. Una auto-narrazione di questo tipo può alimentare ulteriormente il senso di inadeguatezza che impatterà sulle future prestazioni, dando vita ad un vero e proprio circolo vizioso.”
Ansia da prestazione fin da bambini
Quali sono le fasce di età più soggette? “Lo stress emotivo, come risposta alle pressioni scolastiche e universitarie, è un problema trasversale a tutte le età, con manifestazioni e sintomatologie diverse a seconda delle sfide evolutive che quel periodo della crescita implica. Dopo tre anni di solarità e socializzazione durante il triennio dell’asilo, per esempio, la piccola Giorgia di soli 6 anni ha iniziato, dopo le prime settimane di scuola elementare, ad avere sensazioni di vomito tutte le mattine prima del passaggio del bus, ad eccezione dei weekend. Fin dal secondo giorno di scuola media, Filippo, che fino ad allora era stato uno studente brillante, ha iniziato a presentare disturbi del sonno che finivano con il renderlo assente a lezione e, nonostante studiasse fino a notte fonda, le verifiche in classe erano spesso consegnate in bianco. Quando mancavano appena due esami dalla laurea triennale, Alessandro è rimasto due anni senza mettere più piede all’università, nonostante avesse già redatto anche la tesi. Tutte queste storie sono esempi di situazioni di disagio e stress che possono diventare più intense e paralizzanti nei periodi di cambiamento, già di per sé forieri di nuove difficoltà e sfide, in concomitanza soprattutto con il passaggio da un grado di istruzione all’altro.”Come si manifesta e il rischio di "fobia scolare"
In che modo si manifestano le reazioni nervose e fino a che grado di pericolosità possono spingersi? "Gli ormoni dello stress possono modificare i circuiti cerebrali in via di sviluppo. In particolare, hanno un’influenza sulle connessioni neurali nella corteccia prefrontale che presiede alle funzioni esecutive, fondamentali per il ragionamento, la pianificazione, la risoluzione di problemi, la regolazione delle emozioni e l’attenzione. Molto spesso i bambini reagiscono allo stress somatizzando, con sintomi disparati come dolori alla pancia, emicranie, spossatezza, agitazione, vertigini. Alcuni bambini possono reagire con aggressività e con sfuriate a richieste che percepiscono come eccessivamente frustranti. Crescendo, le reazioni possono diventare più complesse, per cui accanto a tensioni e difficoltà attentive, i preadolescenti possono esperire vissuti di senso di colpa e paura del fallimento, che nei casi più gravi possono comportare fobia scolare, sempre più frequente anche alle scuole elementari. L’ansia da prestazione è molto comune anche tra i giovani universitari".Il ruolo della famiglia e degli insegnanti
Cosa è giusto fare e cosa è invece assolutamente sconsigliato quando ci si trova di fronte a ragazzi in evidente stato di stress emotivo? “Un errore comune è quello di rinforzare involontariamente la strategia disadattiva che lo studente sta utilizzando per alleviare lo stress: durante una seduta di psicoterapia familiare, ripensando al passaggio alle scuole medie di Paolo, 11 anni, i suoi genitori si sono resi conti di aver acconsentito sempre più spesso alle sue richieste di non andare a scuola, avallando quella strategia di evitamento che è poi sfociata in una vera e propria fobia scolare. Allo stesso tempo anche minimizzare ciò che il ragazzo sente (“non c’è bisogno di aver paura, tanto hai studiato tutto il weekend, è solo un test”) o squalificarlo per “l’assurdità” delle sue reazioni (“non c’è bisogno di piangere”, “sono solo capricci”) può alimentare il senso di colpa e il senso di inadeguatezza, anziché alleviarli. Le emozioni, anche quando scaturite da pensieri “sbagliati”, andrebbero sempre accolte e rispettate per comprendere il disagio che lo studente ci sta comunicando. Un confronto non giudicante tra insegnanti e genitori per confrontarsi e riflettere sulle manifestazioni emotive dello studente all’interno dei principali ambienti in cui si muove - quello familiare e quello scolastico - è importante per un intervento coordinato tra caregiver e educatori".