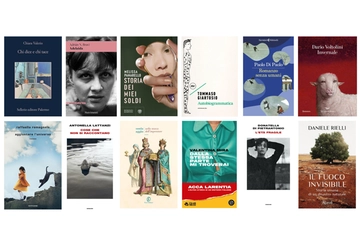Nel primo pomeriggio dell’8 gennaio 2007 Rosa Bazzi e Olindo Romano lasciano Erba a bordo di un’auto dei Carabinieri. Alessandra Carati – finalista al Premio Strega 2022 con ‘E poi saremo salvi’ – conosce Rosa Bazzi nel febbraio 2019.
“Da luglio fino a febbraio dell’anno successivo la incontro ogni settimana, in sessioni che durano ore”. Da questi colloqui è nato ‘Rosy’ (Mondadori). Un’operazione narrativa che potrebbe ricordare romanzi come ‘A sangue freddo’ di Truman Capote o ‘La città dei vivi’ di Nicola Lagioia, che l’hanno guidata nelle prime fasi della ricerca. Poi, con il procedere del tempo è approdata ad altri riferimenti: Annie Ernaux, Joan Didion, Joyce Carol Oates.
“Da principio m’interessava la loro scrittura dal vero, non necessariamente autobiografica. Poi, mi sono appoggiata al ritmo, e da lì ho cercato un modo di trattare la materia narrativa su cui stavo lavorando”.

Le va di raccontarci com’è stato il primo incontro con Rosa Bazzi, come è avvenuto, e quando ha deciso di scrivere questo romanzo?
“Nel febbraio del 2019 chiedo al carcere di partecipare come uditrice a un’intervista che Rosa avrebbe rilasciato. È stata una decisione d’impulso, che non aveva nessuna forma né obiettivo specifico. Anche più avanti, quando avevo già cominciato a visitarla regolarmente, ci sono stati momenti in cui mi chiedevo che cosa stessi cercando. Non approdavo a nulla, non riuscivo a intuire un punto d’attacco, non riuscivo a immaginare una distanza, una focalizzazione, chi avrebbe raccontato la storia. A un certo momento avevo raccolto così tanto materiale ed ero così immersa, che ho smesso di considerare la possibilità di tirarmi indietro. Avevo diverse ragioni per resistere a questo libro, paure legate al groviglio che la vicenda porta con sé. Della strage di Erba si è scritto moltissimo, mi confrontavo con un racconto profondamente cristallizzato e condiviso, e sapevo che sarebbe stato un ostacolo enorme.”
Come ne è uscita?
“Da una prima stesura, che ho completamente accantonato e che mi è servita per mettere ordine nella massa dei documenti processuali e della rassegna stampa, ne è sgorgata una seconda, con una chiara direzione di scrittura. Il libro è un avvicinamento progressivo alla figura di Rosa attraverso gli sguardi di persone che hanno avuto a che fare con lei in questi anni: prima i vicini, poi la stampa, poi la psicologa che li osserva nei mesi di custodia cautelare subito dopo l’arresto, gli avvocati, e solo alla fine il mio su di lei, dentro il carcere. Di fronte a una realtà complessa avevo bisogno di sguardi complementari per poter tentare di comprenderla. La chiave è stata la moltiplicazione dei punti di vista.”

Come mai ha scelto di raccontare solo di lei?
“Non mi ha mai interessato la vicenda in sé, la mia curiosità si è mossa da subito verso Rosa, verso la radicalità della sua esperienza. Desideravo capire. Da principio la sua figura mi respingeva, allo stesso tempo sentivo che c’era qualcosa di profondo che ci accomunava, a dispetto della disparità delle nostre condizioni. Rosa è una donna con deficit cognitivi accertati, che intaccano le sue facoltà intellettive, di memoria, di linguaggio, il pensiero astratto. Non legge e non scrive, non fa semplici calcoli. Per una persona così il mondo si restringe, lei ha bisogno di aiuto per fronteggiare semplici situazioni come pagare una bolletta o prendere un treno. Da qui, forse, si origina la sua dipendenza da Olindo, che è anche una dipendenza pratica. Le recenti perizie parlano per entrambi di un disturbo dipendente di personalità, che assume caratteristiche diverse per l’uno e per l’altra. Un disturbo che rende la separazione della coppia l’angoscia più grande, più pericolosa, più spaventosa, tanto da farli dubitare di poter sopravvivere in assenza dell’altro. Tutte queste fragilità rendono Rosa una persona vulnerabile, la espongono alla manipolazione, all’abuso. Un rischio in cui altre donne incorrono, per mancanza di mezzi, per povertà relazionale e culturale, per solitudine. È come se lei incarnasse quello che più ci spaventa, nelle sue forme più estreme.”
Eppure, verso la fine del romanzo, pare che Rosa quasi si emancipi.
“Un salto mortale, del tutto inaspettato anche per me. In questi diciassette anni, dopo lo smarrimento iniziale, ha imparato a sopravvivere nella condizione complicata e faticosa della detenzione e, anche attraverso l’aiuto e il sostegno degli operatori, si è guadagnata una pista di emancipazione attraverso il lavoro. Nel luogo in cui è più facile perdersi, lei ha acquisito uno spazio di autonomia rispetto al marito, e un senso diverso di sé.”
A proposito di questo, lei definisce Rosa una bambina di 55 anni che si trova a scontare la pena dell’ergastolo. Avvicinarsi a lei è stato come avvicinarsi a un abisso?
“Più che a un abisso, a un enigma, qualcosa di difficile decifrazione: Rosa non è conforme. Le zone grigie sono il territorio della scrittura; i confini incerti dove avvengono gli eccessi, gli abusi, e dove, proprio per questo, la responsabilità, la scelta, il libero arbitrio sono più profondamente esplorabili.”
Nel suo romanzo racconta che per l’avvocata “il momento più pesante è l’inizio, quando preparano il primo grado.” Il problema non sono le indagini ma il clima. La strage di Erba è stata da subito un “caos mediatico”, più che un caso. L’avvocata dice: “Se potessi tornare indietro non sceglierei di nuovo di assisterli”. Per quanto riguarda l’avvocato, invece, lei scrive: “C’è stato qualche momento, nei dodici anni passati, in cui ha pensato di lasciar perdere. Come poteva? Oltre a loro due, avrebbe tradito tutto di sé, la professione, e il senso che tenta di darsi come essere umano”. Per lei com’è stato pubblicare questo libro e qual è stato il feedback che ha ricevuto finora?
“Ci sono lettori disponibili che hanno accolto con grande calore il libro e contemporaneamente c’è una forte resistenza: alcuni mettono in discussione, in modo anche aggressivo, persino l’opportunità che io abbia lavorato a questa storia. Mi fanno ripensare a un’intuizione di Emmanuel Carrère in ‘V13’: uno scrittore è legittimato solo dal proprio desiderio.”
Ha mai pensato, come gli avvocati, di lasciar perdere?
“Sì, certo, in due momenti: all’inizio, per diversi mesi, e poi dopo la prima stesura, per alcune settimane. Durante il lavoro mi sono imbattuta ne ‘L’impostore’ di Javier Cercas – la storia di come un uomo, Enric Marco, si è finto un sopravvissuto all’Olocausto per trent’anni, senza che nessuno in Spagna dubitasse di lui, anzi ricevendo tributi e riconoscimenti, fino allo smascheramento finale. Nel prologo Cercas rivela le ragioni che per anni l’hanno tenuto lontano dalla scrittura del libro, dice che non sapeva perché non volesse scriverlo, oppure lo sapeva ma non voleva riconoscerlo o non osava riconoscerlo. Ora, dopo averlo fatto, sa perché non voleva. Perché aveva paura. E oggi sa che la sua paura era giustificata. Nella storia di Enric Marco ‘tutti fanno una figura di merda, a partire dallo stesso Enric, per arrivare ai giornalisti e agli storici e per finire con i politici; insomma, il Paese al completo. Per raccontare la storia di Enric, bisogna infilare il dito negli occhi di tutti e questo non piace a nessuno.’