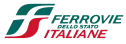ConflittiEfame
La fame nel mondo non arresta la sua corsa. Milioni di persone, di uomini, donne e soprattutto bambini, ogni giorno – o meglio, per giorni – non hanno nulla da mangiare. Immagini che appaiono lontane dal nostro quotidiano, ma che non ci possono far distogliere gli occhi da chi, solo per essere nato in un altro Stato, da un'altra parte nel mondo, più povera, più colpita dai cambiamenti climatici, e indebolita dalla forbice delle disuguaglianze che, con il passare dei decenni diventa sempre più ampia, considera preziose cose che per noi costituiscono la normalità, il quotidiano, e che spesso diamo per scontate. Come un pezzo di pane che avanza, un bicchiere d'acqua che si rovescia, un piatto che non ci piace e che gettiamo via. Non conosciamo l'assenza di cibo per settimane intere, ma non possiamo ignorare che colpisca esseri umani come noi. In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, che si tiene ogni anno il 16 ottobre, la fondazione Cesvi ha presentato la 16esima edizione italiana dell’Indice Globale della Fame, durante un incontro (è possibile rivederlo qui) che si è tenuto giovedì 14 ottobre al quale è intervenuto anche Maurizio Martina, già ministro delle Politiche agricole e attuale vicedirettore generale della FAO. Il Global Hunger Index (GHI) è uno dei principali rapporti internazionali per la misurazione della fame nel mondo, realizzato da Welthungerhife e Concern Wordlwide, due organizzazioni umanitarie che fanno parte del network europeo Alliance 2015, così come Cesvi, che ne cura l'edizione per il nostro Paese. L'analisi ha preso in considerazione 116 Paesi in cui è stato possibile calcolare il punteggio dell'indice sulla base di quattro indicatori: denutrizione, deperimento infantile, arresto della crescita infantile e mortalità dei bambini sotto i cinque anni.
 Il focus di quest'anno era l'intersezione di conflitti e fame, e i passi necessari per rompere i vincoli tra queste due piaghe. "La lotta alla fame è pericolosamente fuori strada. È urgente spezzare il circolo vizioso con cui fame e conflitto si alimentano l’un l’altro. Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura – ha commentato la presidente di Fondazione Cesvi Gloria Zavatta –. Allo stesso modo è necessario intervenire sulle conseguenze drammatiche della pandemia e sugli effetti devastanti del cambiamento climatico. Senza perdere l'obiettivo sulle cause profonde, a cominciare da povertà, disuguaglianze e sistemi alimentari insostenibili". L’organizzazione umanitaria ha realizzato anche un video che racconta in concreto quanto riportato dal GHI 2021:
Il focus di quest'anno era l'intersezione di conflitti e fame, e i passi necessari per rompere i vincoli tra queste due piaghe. "La lotta alla fame è pericolosamente fuori strada. È urgente spezzare il circolo vizioso con cui fame e conflitto si alimentano l’un l’altro. Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura – ha commentato la presidente di Fondazione Cesvi Gloria Zavatta –. Allo stesso modo è necessario intervenire sulle conseguenze drammatiche della pandemia e sugli effetti devastanti del cambiamento climatico. Senza perdere l'obiettivo sulle cause profonde, a cominciare da povertà, disuguaglianze e sistemi alimentari insostenibili". L’organizzazione umanitaria ha realizzato anche un video che racconta in concreto quanto riportato dal GHI 2021:
 Quasi dimezzato, più lentamente, ma comunque in discesa. Guardando ai grafici contenuti nel rapporto, l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale sono le regioni con i livelli di fame più alti al mondo, con punteggi rispettivamente di 27,1 e 26,1 (fame "grave"). La prima, in particolare, registra i tassi di denutrizione, arresto della crescita e mortalità infantile più elevati, ma a preoccupare è soprattutto il fatto che l’Africa è l'unica regione del Pianeta per la quale si prevede un aumento delle persone denutrite da qui al 2030, anno in cui si stima potrebbero essere alla pari con l'Asia. Qui l'alto livello di fame invece deriva perlopiù dalla malnutrizione infantile. Nella classifica dei Paesi fanalino di coda è la Somalia che registra un livello di fame "estremamente allarmante" (50,8 punti), seguìta da nove Stati con un livello "allarmante" e 37 in cui la denutrizione risulta "grave". È il caso, ad esempio, dell' Afghanistan, di Haiti, dell'India e del Venezuela. Tra i Paesi in cui invece il rischio è "moderato" spiccano i piccolissimi Guyana, Suriname e Capo Verde.
Quasi dimezzato, più lentamente, ma comunque in discesa. Guardando ai grafici contenuti nel rapporto, l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale sono le regioni con i livelli di fame più alti al mondo, con punteggi rispettivamente di 27,1 e 26,1 (fame "grave"). La prima, in particolare, registra i tassi di denutrizione, arresto della crescita e mortalità infantile più elevati, ma a preoccupare è soprattutto il fatto che l’Africa è l'unica regione del Pianeta per la quale si prevede un aumento delle persone denutrite da qui al 2030, anno in cui si stima potrebbero essere alla pari con l'Asia. Qui l'alto livello di fame invece deriva perlopiù dalla malnutrizione infantile. Nella classifica dei Paesi fanalino di coda è la Somalia che registra un livello di fame "estremamente allarmante" (50,8 punti), seguìta da nove Stati con un livello "allarmante" e 37 in cui la denutrizione risulta "grave". È il caso, ad esempio, dell' Afghanistan, di Haiti, dell'India e del Venezuela. Tra i Paesi in cui invece il rischio è "moderato" spiccano i piccolissimi Guyana, Suriname e Capo Verde.
 sempre più comuni e prolungate, restano infatti la principale causa della mancanza di alimentazione per gran parte della popolazione globale. Nel 2020 erano 169 i conflitti attivi e non a caso 8 dei 10 Paesi con livelli di fame "allarmanti" o "estremamente allarmanti" coincidono con teatri di guerra: dalla Repubblica Democratica del Congo alla Nigeria, dal Sud Sudan alla Siria fino a Yemen e Somalia. Le due piaghe sono legate con un doppio, strettissimo, filo; ogni aspetto del sistema alimentare, dalla produzione alla diffusione al consumo, è inevitabilmente compromesso dalla violenza e dalle armi. E tra le principali eredità di una guerra c'è, purtroppo, un'insicurezza alimentare duratura, la quale, come un cane che si morde la coda, può condurre a conflitti violenti. "Conflitti e fame si rafforzano a vicenda, dobbiamo affrontarli insieme per porre fine a questo circolo vizioso, attraverso interventi umanitari e progetti di sviluppo ben coordinati e complementari. Gli interventi che aumentano la resilienza e l'inclusività dei mezzi di sussistenza basati sull'agricoltura e supportano la sicurezza alimentare hanno un ruolo importante nella promozione della pace, poiché affrontano non solo i sintomi ma anche le cause profonde del conflitto", ha detto Maurizio Martina intervenendo alla presentazione dell'Indice della Fame.
sempre più comuni e prolungate, restano infatti la principale causa della mancanza di alimentazione per gran parte della popolazione globale. Nel 2020 erano 169 i conflitti attivi e non a caso 8 dei 10 Paesi con livelli di fame "allarmanti" o "estremamente allarmanti" coincidono con teatri di guerra: dalla Repubblica Democratica del Congo alla Nigeria, dal Sud Sudan alla Siria fino a Yemen e Somalia. Le due piaghe sono legate con un doppio, strettissimo, filo; ogni aspetto del sistema alimentare, dalla produzione alla diffusione al consumo, è inevitabilmente compromesso dalla violenza e dalle armi. E tra le principali eredità di una guerra c'è, purtroppo, un'insicurezza alimentare duratura, la quale, come un cane che si morde la coda, può condurre a conflitti violenti. "Conflitti e fame si rafforzano a vicenda, dobbiamo affrontarli insieme per porre fine a questo circolo vizioso, attraverso interventi umanitari e progetti di sviluppo ben coordinati e complementari. Gli interventi che aumentano la resilienza e l'inclusività dei mezzi di sussistenza basati sull'agricoltura e supportano la sicurezza alimentare hanno un ruolo importante nella promozione della pace, poiché affrontano non solo i sintomi ma anche le cause profonde del conflitto", ha detto Maurizio Martina intervenendo alla presentazione dell'Indice della Fame.
 La Fao ipotizza che per effetto della pandemia, nel 2030 le persone denutrite saranno 657 milioni, circa 30 milioni in più di oggi. "Secondo l’Oms, entro il 2030 solo il 25% dei Paesi sembra in grado di dimezzare il numero di bambini affetti da arresto della crescita e solo il 28% di far scendere il deperimento infantile al di sotto del 3% e mantenerlo a questo livello[...] – ha spiegato Valeria Emmi, advocacy senior specialist di Fondazione Cesvi –. Dati che ci fanno allarmare. In questo scenario la crisi pandemica non fa altro che aggravare la situazione. La precarietà dei sistemi alimentari e il conseguente aumento delle persone in situazione di grave insicurezza alimentare richiedono quindi azioni urgenti e consistenti. Tra queste, è necessario un cambiamento radicale dei nostri sistemi alimentari". Quello presentato da Cesvi nell'Indice Globale della Fame appare quindi come un panorama a tinte fosche, che vanno scurendosi come conseguenza delle "tre C", le tre cause principali che condizionano la situazione alimentare mondiale in questo momento storico particolare: conflitti, cambiamenti climatici, coronavirus. Invertire la rotta, però, si può. Anche in un ambiente globale ostile è indispensabile rompere i legami tra conflitto e fame, e intervenire a livello politico per implementare il diritto umanitario internazionale, sanzionando chi vìola il diritto umano al cibo, ricorrendo ad esempio alla fame come arma di guerra o inibendo l'accesso degli aiuti umanitari.
La Fao ipotizza che per effetto della pandemia, nel 2030 le persone denutrite saranno 657 milioni, circa 30 milioni in più di oggi. "Secondo l’Oms, entro il 2030 solo il 25% dei Paesi sembra in grado di dimezzare il numero di bambini affetti da arresto della crescita e solo il 28% di far scendere il deperimento infantile al di sotto del 3% e mantenerlo a questo livello[...] – ha spiegato Valeria Emmi, advocacy senior specialist di Fondazione Cesvi –. Dati che ci fanno allarmare. In questo scenario la crisi pandemica non fa altro che aggravare la situazione. La precarietà dei sistemi alimentari e il conseguente aumento delle persone in situazione di grave insicurezza alimentare richiedono quindi azioni urgenti e consistenti. Tra queste, è necessario un cambiamento radicale dei nostri sistemi alimentari". Quello presentato da Cesvi nell'Indice Globale della Fame appare quindi come un panorama a tinte fosche, che vanno scurendosi come conseguenza delle "tre C", le tre cause principali che condizionano la situazione alimentare mondiale in questo momento storico particolare: conflitti, cambiamenti climatici, coronavirus. Invertire la rotta, però, si può. Anche in un ambiente globale ostile è indispensabile rompere i legami tra conflitto e fame, e intervenire a livello politico per implementare il diritto umanitario internazionale, sanzionando chi vìola il diritto umano al cibo, ricorrendo ad esempio alla fame come arma di guerra o inibendo l'accesso degli aiuti umanitari.
 Il focus di quest'anno era l'intersezione di conflitti e fame, e i passi necessari per rompere i vincoli tra queste due piaghe. "La lotta alla fame è pericolosamente fuori strada. È urgente spezzare il circolo vizioso con cui fame e conflitto si alimentano l’un l’altro. Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura – ha commentato la presidente di Fondazione Cesvi Gloria Zavatta –. Allo stesso modo è necessario intervenire sulle conseguenze drammatiche della pandemia e sugli effetti devastanti del cambiamento climatico. Senza perdere l'obiettivo sulle cause profonde, a cominciare da povertà, disuguaglianze e sistemi alimentari insostenibili". L’organizzazione umanitaria ha realizzato anche un video che racconta in concreto quanto riportato dal GHI 2021:
Il focus di quest'anno era l'intersezione di conflitti e fame, e i passi necessari per rompere i vincoli tra queste due piaghe. "La lotta alla fame è pericolosamente fuori strada. È urgente spezzare il circolo vizioso con cui fame e conflitto si alimentano l’un l’altro. Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura – ha commentato la presidente di Fondazione Cesvi Gloria Zavatta –. Allo stesso modo è necessario intervenire sulle conseguenze drammatiche della pandemia e sugli effetti devastanti del cambiamento climatico. Senza perdere l'obiettivo sulle cause profonde, a cominciare da povertà, disuguaglianze e sistemi alimentari insostenibili". L’organizzazione umanitaria ha realizzato anche un video che racconta in concreto quanto riportato dal GHI 2021:
Cosa emerge dell'Indice
Quella che è emersa è una preoccupante battuta d'arresto nella lotta alla fame, tanto che l'obiettivo "Fame Zero" entro appare sempre più lontano. Dopo decenni di declino, come in effetti emerge dai dati, dal 2000 ad oggi, la denutrizione sta tornando drammaticamente ad aumentare. Combinando infatti gli effetti di conflitti armati, cambiamento climatico e pandemia il rischio è quello di vedere polverizzati tutti i progressi compiuti negli ultimi anni (anche se lenti e difficoltosi) verso l’obiettivo di azzeramento della fame fissato dalle Nazioni Unite al 2030. Nel 2020, infatti, a causa di questa 'combo' devastante, la percentuale di popolazione denutrita nel mondo è tornata a salire: sono 155 milioni le persone in stato di insicurezza alimentare acuta, 20 milioni in più rispetto al 2019 (55 Paesi analizzati, fonte Gnafc, Global Report on food crises 2021). Secondo l’Indice Globale della Fame 2021, in 47 Paesi in particolare, il dato sulla fame resta dunque eccezionalmente elevato, con scarse possibilità di ridurlo a livelli bassi entro la fine del decennio. Previsioni a dir poco fosche.Lo stato della fame nel mondo
Tra il 2006 e il 2012 il punteggio mondiale sulla denutrizione è sceso di 4,7 punti. Negli ultimi nove anni, invece, è diminuito di soli 2,5 punti.
Haiti, Cesvi/Charly Amzan
I conflitti, la prima causa di denutrizione
Il focus del GHI di quest'anno, come abbiamo visto, riguarda lo stretto legame che intercorre tra conflitti armati e aumento della fame nel mondo. Le guerre, sempre più diffuse,
Somalia, Cesvi / Fulvio Zubiani
Gli effetti della pandemia
Non ne siamo ancora usciti e sicuramente ci vorrà del tempo per avere dei dati assoluti, gli effetti della pandemia sull'aumento della fame sono innegabili e già oggi appare evidente come lo shock economico derivato abbia pregiudicato la sicurezza alimentare globale. La stima sul numero di persone in situazione di insicurezza alimentare acuta parla di un aumento di quasi 20 milioni nel 2020 rispetto all'anno precedente.
Myanmar, Cesvi