
Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca
La Crusca spiega come scrivere gli atti giudiziari per rispettare la parità di genere. Sollecitata da una richiesta del Comitato pari opportunità del Consiglio direttivo della Cassazione, l’Accademia della Crusca - massima istituzione linguistica italiana, presieduta dal professore Claudio Marazzini – dà una serie di indicazioni su come scrivere correttamente gli atti formali. “A chi opera nel settore del diritto e dell’amministrazione della giustizia, così come a chi opera nella burocrazia delle istituzioni pubbliche è richiesto di scrivere in modo chiaro e sintetico, secondo regole che da tempo sono state indicate, per le quali è necessario un addestramento attento e continuo che ne renda naturale e automatico il rispetto” dice Marazzini, sottolineando che tali indicazioni non sono coercitive della lingua italiana bensì legate all’ambito di una scrittura professionale per darle omogeneità.

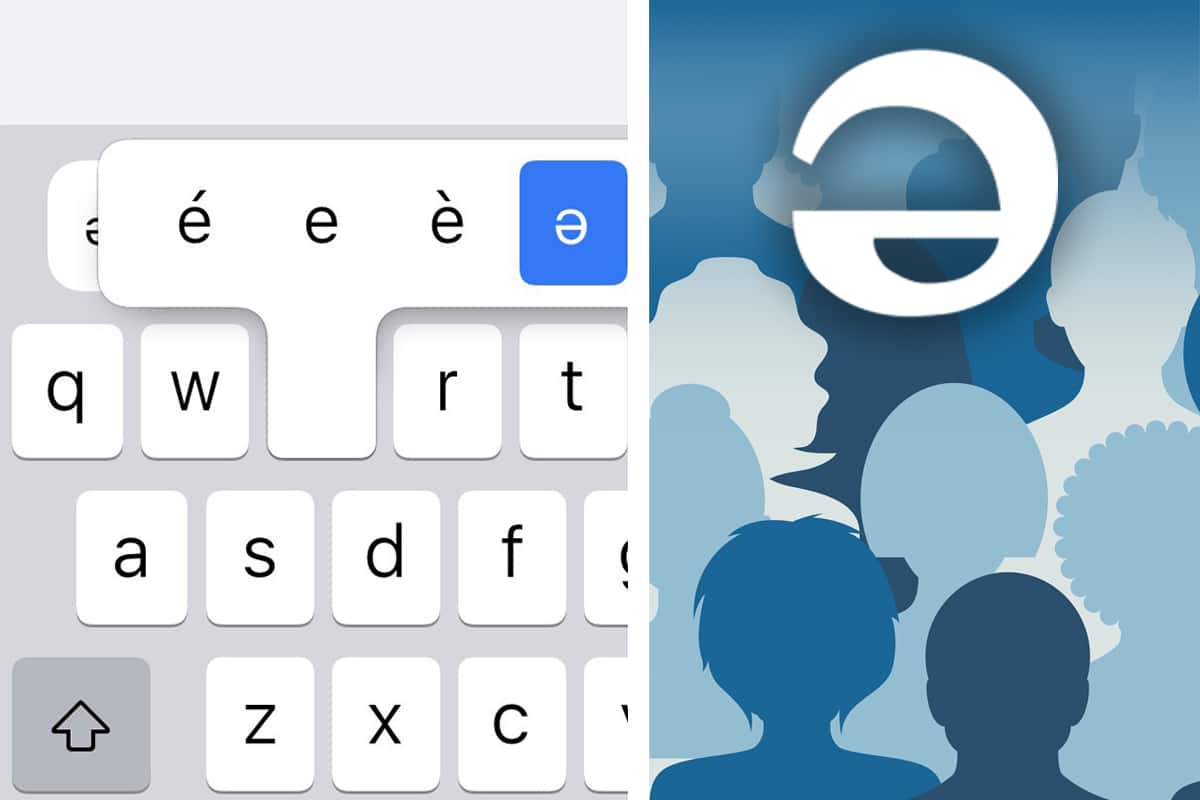
 Per i nomi composti con vice-, pro-, sotto-, sintagmi con vicario, sostituto, aiuto conta il genere della persona che deve portare l'appellativo: se è donna andrà al femminile secondo le regole del sostantivo indicante il ruolo, se è uomo andrà al maschile, senza considerare il genere della persona di cui è vice, vicaria/vicario, sostituta/sostituto.
Per i nomi composti con vice-, pro-, sotto-, sintagmi con vicario, sostituto, aiuto conta il genere della persona che deve portare l'appellativo: se è donna andrà al femminile secondo le regole del sostantivo indicante il ruolo, se è uomo andrà al maschile, senza considerare il genere della persona di cui è vice, vicaria/vicario, sostituta/sostituto.

Il professore Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca
Stop alla schwa e agli asterischi
Da escludere assolutamente, nella compilazione degli atti giudiziari, “l’uso di segni grafici che non abbiano una corrispondenza nel parlato”, come “l’asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico” dice Marazzini. Stesso discorso per la scevà o schwa, cioè l'ǝ dell'alfabeto fonetico internazionale che rappresenta la vocale centrale propria di molte lingue. “La lingua giuridica – aggiunge il professore - non è sede adatta per sperimentazioni innovative minoritarie che porterebbero alla disomogeneità e all'idioletto”Sì all’uso del maschile plurale non marcato
In una lingua come l’italiano, che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, “lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continua a essere il maschile plurale non marcato, purché si abbia la consapevolezza - sottolinea Marazzini - di quello che effettivamente è un modo di includere e non di prevaricare”. Marazzini ricorda che in contesti di pubblica oratoria “lavoratori e lavoratrici” va bene ma negli atti giudiziari, proprio per questioni di sintesi, è giusto utilizzare il maschile “o si possono scegliere altre forme neutre o generiche, per esempio sostituendo ‘lavoratori e lavoratrici’ con ‘dipendenti’”. La Crusca, quindi, dà il via libera al maschile non marcato che in molti casi è inevitabile: “se lo si volesse annullare interpretando il maschile in maniera assurdamente rigida, occorrerebbe rivedere tutti i testi scritti italiani, compresi quelli giuridici, occorrerebbe insomma riscrivere milioni di pagine, a cominciare dalla Costituzione della Repubblica, che parla di 'cittadini', senza reduplicare 'cittadini e cittadine', ma intendendo che i diritti dei cittadini sono anche quelli delle cittadine” ricorda Marazzini.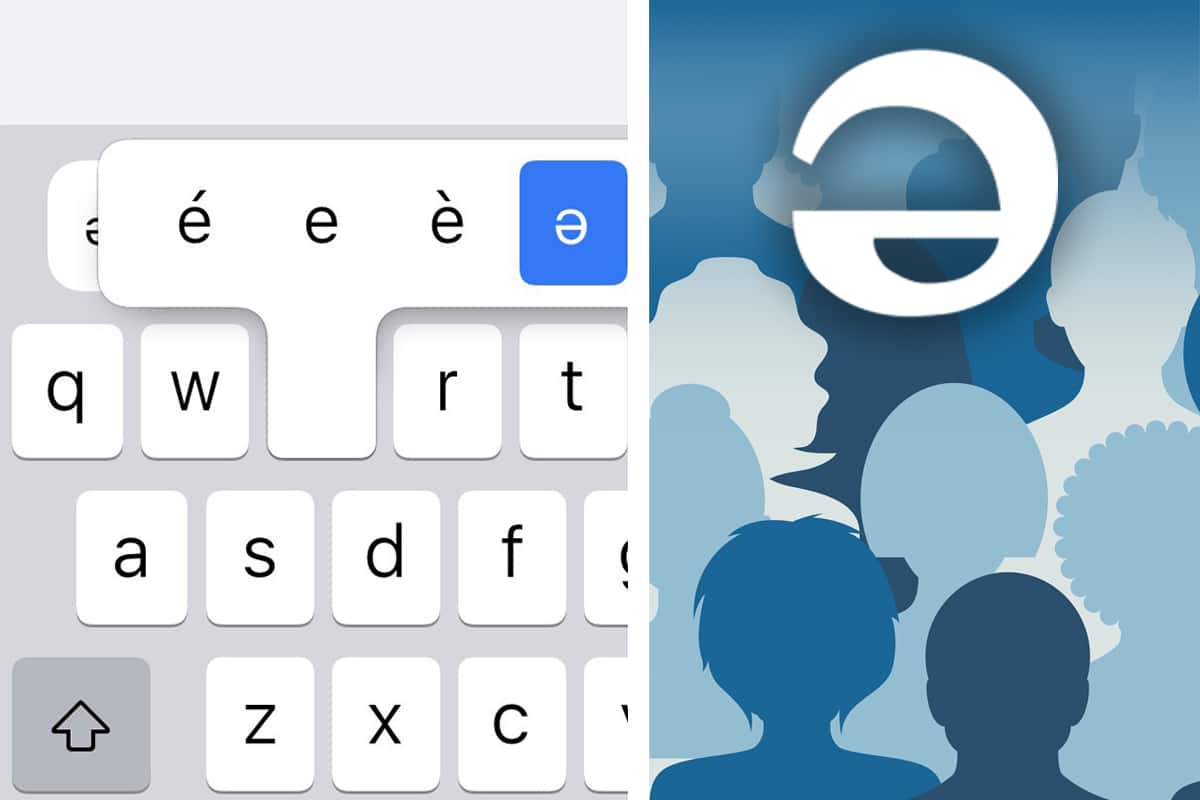
No alla Schwa e all'uso di asterischi
Sì al femminile nei nomi delle professioni
La massima istituzione linguistica italiana invita a fare “largo uso e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile”. Pertanto, in base all'applicazione delle normali regole di grammatica i nomi terminanti al maschile in -o hanno il femminile in -a: magistrato/magistrata; prefetto/prefetta; avvocato/avvocata; segretario/segretaria, segretario generale / segretaria generale; delegato/delegata; perito/perita; architetto/architetta; medico/medica; chirurgo/chirurga; maresciallo/marescialla; capitano/capitana; colonnello/colonnella. Anche per i nomi composti si può usare il femminile: “pubblica ministera” è corretto, così come “sostituta procuratrice”. “Suonano male? E’ solo questione d’abitudine” dice Marazzini annunciando che la Treccani ha già inserito anche la parola “medica”, ovvero la donna medico. L'Accademia della Crusca ricorda che i nomi terminanti in -e non suffissati sono ambigenere, cioè possono essere sia maschili che femminili e affidano l'indicazione del genere all'articolo (e stabiliscono l'accordo di altri elementi come aggettivi, participi…): il preside / la preside; il presidente / la presidente; il docente / la docente; il testimone / la testimone; il giudice / la giudice; il sottufficiale / la sottufficiale; il tenente / la tenente; il maggiore / la maggiore. Esempi con aggettivo: il consulente tecnico / la consulente tecnica; il giudice istruttore / la giudice istruttrice. Fanno eccezione forme ormai entrate nello standard come studente/studentessa, professore/professoressa.
La massima istituzione linguistica italiana invita a fare “largo uso e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile